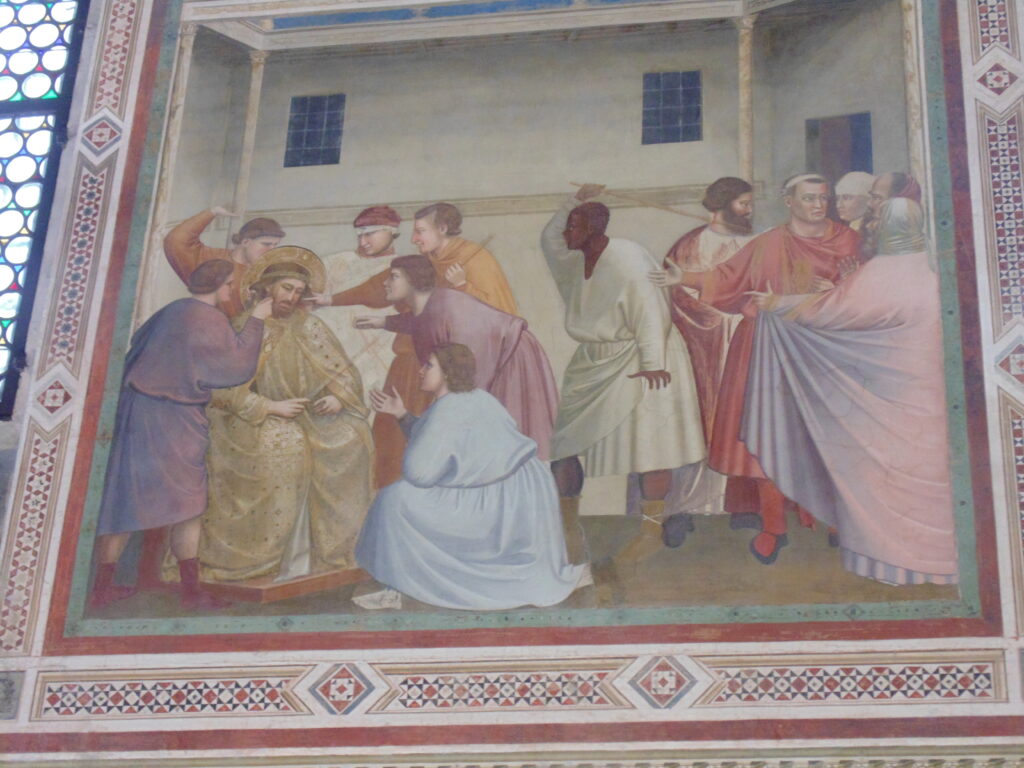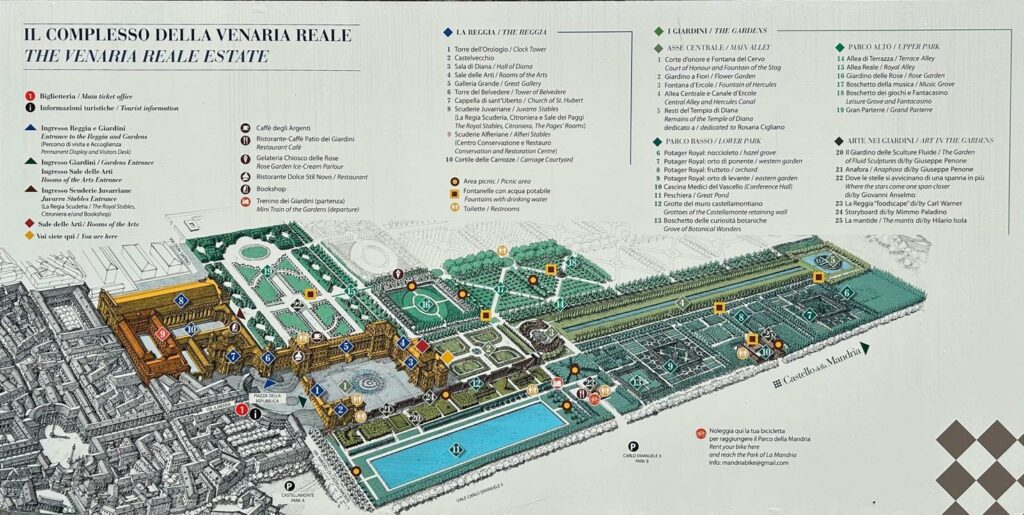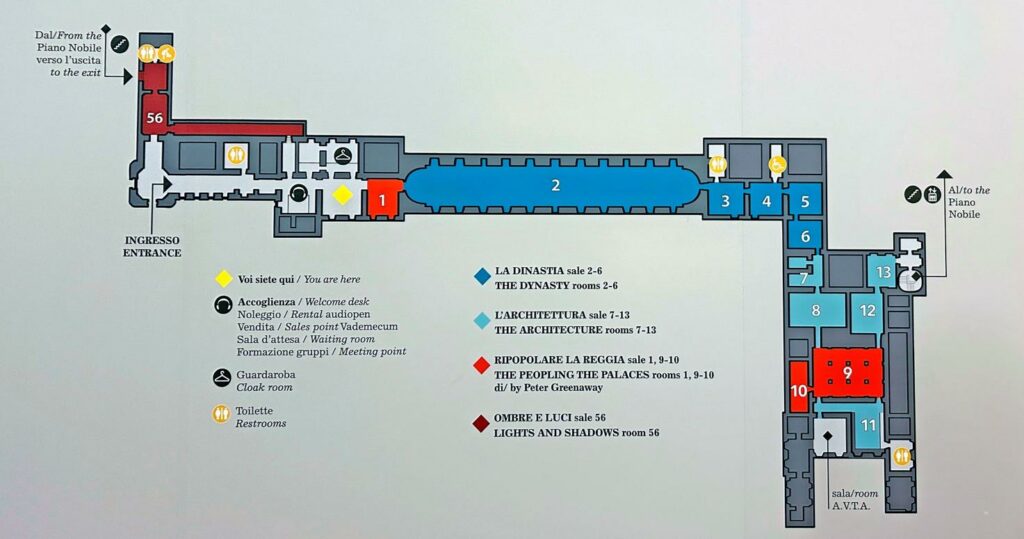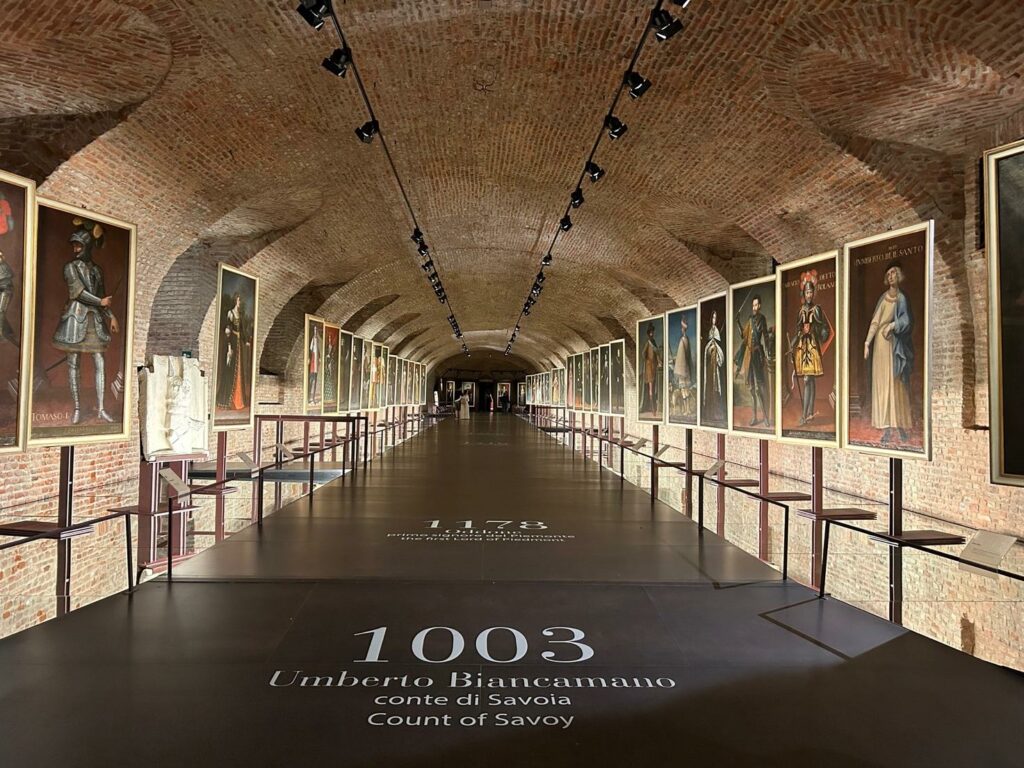Se questo è un uomo – Primo Levi – La Partenza da Fossoli
Come ebreo, venni inviato a Fossoli, presso Modena, dove un vasto campo di internamento, già destinato ai prigionieri di guerra inglesi e americani, andava raccogliendo gli appartenenti alle numerose categorie di persone non gradite al neonato governo fascista repubblicano.
Al momento del mio arrivo, e cioè alla fine del gennaio 1944, gli ebrei italiani nel campo erano centocinquanta circa, ma entro poche settimane il loro numero giunse a oltre seicento. Si trattava per lo più di intere famiglie, catturate dai fascisti o dai nazisti per loro imprudenza, o in seguito a delazione. Alcuni pochi si erano consegnati spontaneamente, o perché ridotti alla disperazione dalla vita randagia, o perché privi di mezzi, o per non separarsi da un congiunto catturato, o anche, assurdamente, per “mettersi in ordine con la legge”. V’erano inoltre un centinaio di militari jugoslavi internati, e alcuni altri stranieri considerati politicamente sospetti. (…)
Ma il mattino del 21 si seppe che l’indomani gli ebrei sarebbero partiti. Tutti: nessuna eccezione. Anche i bambini, anche i vecchi, anche i malati. Per dove, non si sapeva. Prepararsi per quindici giorni di viaggio. Per ognuno che fosse mancato all’appello, dieci sarebbero stati fucilati.
Soltanto una minoranza di ingenui e di illusi si ostinò nella speranza: noi avevamo parlato a lungo coi profughi polacchi e croati, e sapevamo che cosa volesse dire partire.
Nei riguardi dei condannati a morte, la tradizione prescrive un austero cerimoniale, atto a mettere in evidenza come ogni passione e ogni collera siano ormai spente, e come l’atto di giustizia non rappresenti che un triste dovere verso la società, tale da potere accompagnarsi a pietà verso la vittima da parte dello stesso giustiziere. Si evita perciò al condannato ogni cura estranea, gli si concede la solitudine, e, ove lo desideri, ogni conforto spirituale, si procura insomma che egli non senta intorno a sé l’odio o l’arbitrio, ma la necessità e la giustizia, e, insieme con la punizione, il perdono.
Ma a noi questo non fu concesso, perché eravamo troppi, e il tempo era poco, e poi, finalmente, di che cosa avremmo dovuto pentirci, e di che cosa venir perdonati? Il commissario italiano dispose dunque che tutti i servizi continuassero a funzionare fino all’annunzio definitivo; la cucina rimase perciò in efficienza, le corvées di pulizia lavorarono come di consueto, e perfino i maestri e i professori della piccola scuola tennero lezione a sera, come ogni giorno. Ma ai bambini quella sera non fu assegnato compito.
E venne la notte, e fu una notte tale, che si conobbe che occhi umani non avrebbero dovuto assistervi e sopravvivere. Tutti sentirono questo: nessuno dei guardiani, né italiani né tedeschi, ebbe animo di venire a vedere che cosa fanno gli uomini quando sanno di dover morire.
Ognuno si congedò dalla vita nel modo che più gli si addiceva.
Alcuni pregarono, altri bevvero oltre misura, altri si inebriarono di nefanda ultima passione. Ma le madri vegliarono a preparare con dolce cura il cibo per il viaggio, e lavarono i bambini, e fecero i bagagli, e all’alba i fili spinati erano pieni di biancheria infantile stesa al vento ad asciugare; e non dimenticarono le fasce, e i giocattoli, e i cuscini, e le cento piccole cose che esse ben sanno, e di cui i bambini hanno in ogni caso bisogno. Non fareste anche voi altrettanto? Se dovessero uccidervi domani col vostro bambino, voi non gli dareste oggi da mangiare? (…)
I vagoni erano dodici, e noi seicentocinquanta; nel mio vagone eravamo quarantacinque soltanto, ma era un vagone piccolo. Ecco dunque, sotto i nostri occhi, sotto i nostri piedi, una delle famose tradotte tedesche, quelle che non ritornano, quelle di cui, fremendo e sempre un poco increduli, avevamo così spesso sentito narrare. Proprio così, punto per punto: vagoni merci, chiusi dall’esterno, e dentro uomini donne bambini, compressi senza pietà, come merce di dozzina, in viaggio verso il nulla, in viaggio all’ingiù, verso il fondo. Questa volta dentro siamo noi. (…)
Il treno viaggiava lentamente, con lunghe soste snervanti. Dalla feritoia, vedemmo sfilare le alte rupi pallide della val d’Adige, gli ultimi nomi di città italiane. Passammo il Brennero alle dodici del secondo giorno, e tutti si alzarono in piedi, ma nessuno disse parola. Mi stava nel cuore il pensiero del ritorno, e crudelmente mi rappresentavo quale avrebbe potuto essere la inumana gioia di quell’altro passaggio, a portiere aperte, ché nessuno avrebbe desiderato fuggire, e i primi nomi italiani… e mi guardai intorno, e pensai quanti, fra quella povera polvere umana, sarebbero stati toccati dal destino.
Fra le quarantacinque persone del mio vagone, quattro soltanto hanno rivisto le loro case; e fu di gran lunga il vagone piu fortunato. Soffrivamo per la sete e il freddo: a tutte le fermate chiedevamo acqua a gran voce, o almeno un pugno di neve, ma raramente fummo uditi; i soldati della scorta allontanavano chi tentava di avvicinarsi al convoglio. Due giovani madri, coi figli ancora al seno, gemevano notte e giorno implorando acqua. Meno tormentose erano per tutti la fame, la fatica e l’insonnia, rese meno pensose dalla tensione dei nervi: ma le notti erano incubi senza fine.
Pochi sono gli uomini che sanno andare a morte con dignità, e spesso non quelli che ti aspetteresti. Pochi sanno tacere, e rispettare il silenzio altrui. Il nostro sonno inquieto era interrotto sovente da liti rumorose e futili, da imprecazioni, da calci e pugni vibrati alla cieca come difesa contro qualche contatto molesto e inevitabile. Allora qualcuno accendeva la lugubre fiammella di una candela, e rivelava, prono sul pavimento, un brulichio fosco, una materia umana confusa e continua, torpida e dolorosa, sollevata qua e là da convulsioni improvvise subito spente dalla stanchezza.
Dalla feritoia, nomi noti e ignoti di città austriache, Salisburgo, Vienna; poi cèche, infine polacche. Alla sera del quarto giorno, il freddo si fece intenso: il treno percorreva interminabili pinete nere, salendo in modo percettibile. La neve era alta. Doveva essere una linea secondaria, le stazioni erano piccole e quasi deserte. Nessuno tentava più, durante le soste, di comunicare col mondo esterno: ci sentivamo ormai “dall’altra parte”. Vi fu una lunga sosta in aperta campagna, poi la marcia riprese con estrema lentezza, e il convoglio si arrestò definitivamente, a notte alta, in mezzo a una pianura buia e silenziosa. Si vedevano, da entrambi i lati del binario, file di lumi bianchi e rossi, a perdita d’occhio; ma nulla di quel rumorio confuso che denunzia di lontano i luoghi abitati. Alla luce misera dell’ultima candela, spento il ritmo delle rotaie, spento ogni suono umano, attendemmo che qualcosa avvenisse.
Accanto a me, serrata come me fra corpo e corpo, era stata per tutto il viaggio una donna. Ci conoscevamo da molti anni, e la sventura ci aveva colti insieme, ma poco sapevamo l’uno dell’altra. Ci dicemmo allora, nell’ora della decisione, cose che non si dicono fra i vivi. Ci salutammo, e fu breve; ciascuno salutò nell’altro la vita. Non avevamo più paura. (…)
Ci apparve una vasta banchina illuminata da riflettori. Poco oltre, una fila di autocarri. Poi tutto tacque di nuovo. Qualcuno tradusse: bisognava scendere coi bagagli, e depositare questi lungo il treno. In un momento la banchina fu brulicante di ombre: ma avevamo paura di rompere quel silenzio, tutti si affaccendavano intorno ai bagagli, si cercavano, si chiamavano l’un l’altro, ma timidamente, a mezza voce. Una decina di SS stavano in disparte, l’aria indifferente, piantati a gambe larghe. A un certo momento, penetrarono fra di noi, e, con voce sommessa, con visi di pietra, presero a interrogarci rapidamente, uno per uno, in cattivo italiano. Non interrogavano tutti, solo qualcuno. “Quanti anni? Sano o malato?” e in base alla risposta ci indicavano due diverse direzioni.
Tutto era silenzioso come in un acquario, e come in certe scene di sogni. Ci saremmo attesi qualcosa di piu apocalittico: sembravano semplici agenti d’ordine. Era sconcertante e disarmante.
Qualcuno osò chiedere dei bagagli: risposero “bagagli dopo”; qualche altro non voleva lasciare la moglie: dissero “dopo di nuovo insieme”; molte madri non volevano separarsi dai figli: dissero “bene bene, stare con figlio”. Sempre con la pacata sicurezza di chi non fa che il suo ufficio di ogni giorno. (…)
Da “Se questo è un uomo” di Primo Levi – Ed, Einaudi